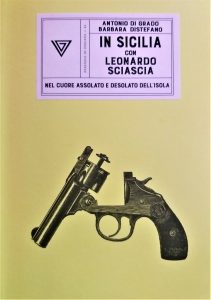Albert Camus
LA PESTE (LA PESTE, 1947)
Trad. di Y. Melaouah
Bompiani, Milano 2019
«Classici contemporanei»
Pagine 326
€ 13,00
Orano è una città qualunque sulla costa algerina, in cui la gente si innamora, guadagna, spende, soffre ed è felice senza sapere perché. Nella cronaca asciutta e quasi naturalistica dell’anonimo narratore a un tratto accade qualcosa di inspiegabile e anche terrificante per la sua strana banalità: i topi della città iniziano a morire a centinaia. Nessuno ha il sentore che possa trattarsi di un flagello dal nome antico ma che non si osa nominare. È la peste, che all’inizio colpisce i roditori – gli storici diffusori del contagio – e infine gli umani. Orano viene blindata.
È straordinario come Camus sia riuscito a predire le dinamiche di un contagio nei minimi dettagli, al punto da dire che, in caso di incongruenze, è la realtà stessa a non aver obbedito alle descrizioni del suo romanzo. Ogni morbo ha la sua storia di accidenti e di sintomi sociali, politici e culturali a seconda dello spaziotempo in cui accade, ma la sostanza rimane immutata.
La peste è l’irruzione di un pericolo sopito divenuto atto, la paura che si fa sensibile e rintracciabile in bubboni, ghiandole ingrossate e febbri estenuanti. Qualcosa che c’è e c’è sempre stato, una naturale componente della vita che quando si manifesta e con il terrore che diffonde induce alla riflessione più profonda.
La città viene chiusa, la distanza sociale viene resa obbligatoria, le navi vengono fatte attraccare, il commercio muore con le relazioni, nelle carceri si creano rovinosi tafferugli, i funerali vengono ridotti a una palata di calce nella prima fossa utile, le preghiere collettive tornano di moda. All’inizio in molti si ostinano a pianificare il loro futuro, a discutere di vacanze e progetti lavorativi, non sapendo però che la peste, la morte imminente, sopprime il futuro e con esso la radice della vita stessa. «Si credevano liberi e nessuno sarà mai libero finché ci saranno dei flagelli»[1].
Sono due i principali sentimenti in questa trappola per topi in forma di città commerciale sul mare, simile a una delle tante in cui secoli e secoli prima il bacillo aveva attecchito: prigionia ed esilio. Tutti erano rinchiusi nella propria abitazione, che piacesse o no, e pur essendo prigionieri si sentivano esiliati da una città e da una realtà domestica che non riconoscevano più.
La peste impigriva, rendeva inerti, rammolliva la volontà come le carni. Essa sembrava un’astrazione, qualcosa di impalpabile e incomprensibile, che uccideva chi implorava che smettesse, chi squarciava il non-senso del mondo, chi cercava con ogni mezzo di guarire. Barricarsi in casa per una resistenza isolata e al contempo collettiva presto divenne insostenibile, un prezzo troppo alto da sopportare anche per i più idealisti.
In un primo tempo tutti avevano accettato di essere isolati dal mondo esterno come avrebbero accettato un inconveniente temporaneo che scombinava solo qualche abitudine. Tuttavia, consapevoli d’un tratto di essere come sequestrati, sotto la cappa del cielo dove iniziava a sfrigolare l’estate, avvertivano confusamente che quella reclusione minacciava tutta la loro vita e, quando arrivava sera, l’energia che ritrovavano con il fresco li spingeva talora ad azioni disperate.[2]
La primavera appena trascorsa era stata rubata dal morbo agli abitanti di Orano: il risveglio del sole e del calore li colpiva ma senza toccarli veramente. La peste stava congelando l’energia vitale che la tanto attesa e gradita estate avrebbe dovuto corroborare. «Il sole della peste spegneva i colori e fugava la gioia»[3]. La peste aveva annullato l’estate, più forte e destinale del calore umano e di quello della stagione. Essa si burlava della paura e dei morti con una giovialità insostenibile. «Il corpo non aveva più diritto alle sue gioie»[4].
La città era una lunga e silenziosa processione di edifici funerari, la cui unica presenza umana erano gli insensati monumenti eretti per rappresentare a futura memoria personaggi illustri «imprigionati per sempre nel bronzo», ottima metafora degli umani del presente rintanati nelle case, negli ospedali, nei campi di cura.
Quegli idoli mediocri troneggiavano sotto un cielo pesante, agli incroci senza vita, come fantocci inerti che ben rappresentavano il regno immobile nel quale eravamo entrati, o perlomeno il suo ordine ultimo, quello di una necropoli dove la peste, la pietra e la notte avrebbero infine zittito qualunque voce.[5]
È una splendida e insieme angosciante immagine della città senza vita, dell’umanità senza gli umani. «La società dei vivi temeva da un giorno all’altro di essere soppiantata dalla società dei morti»[6]. Una società di rimasugli.
E così Orano viveva nella più lacerante delle contraddizioni: adoperare prudenza per vivere e nel frattempo morire di questa stessa prudenza, sentendo la vita scivolare con le stesse gocce di sudore o di pus degli appestati sui letti di morte. Gli umani erano «spinti verso gli altri dal bisogno profondo di calore umano, e tuttavia tenuti distanti dalla diffidenza che impedisce loro di lasciarsi andare»[7].
Con una splendida formula Camus va al cuore di tale contraddizione: «Rieux sapeva cosa pensava in quel preciso istante il vecchio che piangeva, e lo pensava come lui, che quel mondo senza amore era come un mondo morto e che arriva sempre il momento in cui non se ne può più delle prigioni, del lavoro e del coraggio e si implora un volto umano e il cuore incantato della tenerezza»[8]. Tenerezza, dolcezza, vedere nell’altro il sorriso, lo sguardo, l’attenzione, sono le parole della consistenza.
Cosa ha rappresentato il narratore e protagonista dottor Rieux, medico infaticabile che agisce senza sapere perché, che guarisce, si affanna e si srotola per le vie di tale città fantasma? È nell’essenza del medico tentare di guarire, ma la professione di Rieux sembra più teologica che medica. È affranto dalla morte di un bambino e di un amico, viene sopraffatto dall’insensatezza.
In questo personaggio le figure del medico e del filosofo sembrano convergere fino a una perfetta coincidenza: il medico tenta nelle sue possibilità di guarire e tenere vuoti i cimiteri; il filosofo fa lo stesso, tentando di dare un senso a esistenze altrimenti assurde. Egli accetta la verità del mondo, il suo darsi come male, il suo essere così com’è. La peste è dunque il dispositivo con cui l’umano può prendere consapevolezza dell’assurdo in cui si trova. Il medico-filosofo cerca di alleviare il male, rendere più accettabile una realtà che sarebbe insostenibile, perché, in fondo, non c’è nient’altro che valga la pena di fare.
Tuttavia, nelle pagine finali del suo racconto, Rieux comprende la verità dell’umano, esprimendola in una frase che solo la letteratura più alta può produrre e anche sopportare. Rieux aveva conosciuto la verità del flagello nel volto dell’Altro, di chi si salva e di chi muore: «Il calore della vita e un’immagine di morte, era questa la conoscenza»[9]. È una verità che solo la peste come il massimo della privazione, del rischio e del male poteva generare e chiarire. Capito ciò, il dottore può recepire con calma la morte della moglie, partita all’inizio del libro dalla città con un treno.
Il flagello così com’è arrivato scompare. I topi e gli umani tornano a popolare la città. La libertà, la felicità e la gioia di ritrovarsi ridanno speranza e futuro. Grand non ha più bisogno degli aggettivi per rendere più gradevole la sua frase già insulsa. L’aprirsi della speranza aveva reso improvvisamente tutto più giusto. Prima della fine qualcuno continuava a morire, come una sfortunata eccezione, «eppure in tutti gli animi, con settimane di anticipo, i treni già partivano fischiando lungo rotaie infinite mentre le navi solcavano mari pieni di luce»[10].