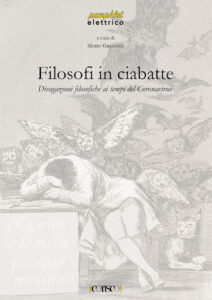Recensione a:
Jean-Claude Michéa
Il nostro comune nemico. Considerazioni sulla fine dei giorni tranquilli
Neri Pozza Editore
Vicenza 2018
Pagine 206
€ 18,00
di Marcosebastiano Patanè
Chi è il nostro comune nemico e chi sono i “noi” che da tale nemico devono proteggersi? Nel titolo originale del testo di Michéa il nemico in questione è da subito nominato: le capital, il capitale. Il noi, invece, chiama in causa in questa contrapposizione il popolo e la società minacciati dalla dinamica disgregatrice e distruttrice dell’accumulazione illimitata del capitale. La fine dei giorni tranquilli è dunque il “nostro” tempo, il tempo cioè della società dei consumi, della società dello spettacolo e dell’utopia tecnologico-salvifica, in realtà una distopia, che domina il mondo globalizzato.
Il testo consta di un’intervista, quattro domande e le rispettive risposte, e sedici scoli in cui Michéa articola la sua analisi della società capitalistico-liberale contemporanea, cioè dei primi due decenni del XXI secolo, e delle sue radici filosofiche, risalendo a tal fine fino ai nodi originari del pensiero illuminista francese.
La trattazione di Michéa prende le mosse da un punto fondamentale che verrà argomentato diverse volte nel corso del testo: nell’epoca del dominio incontrastato del tornaconto capitalistico e del liberalismo trionfante, solamente un recupero dell’eredità del pensiero socialista, anarchico e marxista delle origini può offrire una possibilità di rinascita al consorzio umano. Socialismo, anarchismo e marxismo originari (soprattutto del Marx vicino alle istanze dei populisti russi di XIX-XX secolo) e non l’eredità del pensiero di sinistra, non della sinistra radicale, né della sinistra di sinistra.
La ragione di fondo di tale posizione viene illustrata da Michéa fornendo diversi esempi storici e politici ma soprattutto seguendo un’antinomia filosofica di fondo che vede contrapposti due nuclei fondamentali: l’idea illuminista di progresso e lo spazio della Gemeinschaft, le due estremità di una catena che vedono rispettivamente da un lato la galassia del movimento liberale borghese, di destra e di sinistra, e dall’altro la galassia delle istanze proletarie e più generalmente popolari di socialismo, anarchismo e marxismo.
L’essenza di questa antinomia sta nell’atto di nascita del pensiero di sinistra, che è lo stesso del pensiero liberale: la saldatura, ab origine, tra gli ideali emancipatori dell’illuminismo, primo tra tutti lo scioglimento dei legami feudali, la nascita del liberismo economico (come sottolinea e ricorda giustamente Michéa, Adam Smith conservava un grosso debito nei confronti dei pensatori francesi), le innovazioni tecnologiche della Rivoluzione Industriale e, amalgama fondamentale, l’idea di progresso, vera e propria dimensione religiosa del pensiero liberale.
La missione civilizzatrice di tale religione assume le fattezze di una crociata contro il vecchio mondo, un nemico, questo, sempre in agguato, sempre pronto a distruggere il lavoro dei sacerdoti-missionari «del “senso della Storia”» (p. 80) riavvolgendone il nastro, sempre pronto a vanificare ogni slancio nel mondo nuovo della realizzazione individuale secondo gli schemi, neutri, del calcolo e dell’interesse personale. La dimensione del progresso è infatti accompagnata dall’affermazione del concetto di neutralità assiologica, la neutralità del mercato racchiuso nella massima business is business, e dal fenomeno onnicomprensivo della mobilità, fenomeno fondamentale per la diffusione capillare del mercato.
Michéa cita dalla voce Grano del Dizionario filosofico di Voltaire per mostrare l’entusiasmo del filosofo in merito al concetto di neutralità assiologica che anima il liberalismo economico, sottolineandone il supposto potere pacificatore: «“Intorno al 1750 – scriveva – la nazione, satura di versi, di tragedie, di commedie, di opere, di romanzi, di storie romantiche, di riflessioni morali ancora più romantiche, e di controversie teologiche sulla grazia e sulle convulsioni, si mise infine a ragionare sul raccolto”» (p. 19). Poco più avanti, a proposito della mobilità, Michéa riporta una citazione di Smith dal celebre La ricchezza delle nazioni secondo cui bisogna abolire «tutto quello che può “ostacolare la libera circolazione del lavoro e dei capitali, tanto da un impiego a un altro quanto da un luogo a un altro”» (ibidem).
La rimozione di ogni ostacolo alla diffusione del mercato altro non è se non l’affermazione dell’accumulazione illimitata del capitale secondo i principi della competizione, ennesimo mito della società liberale che nasconde la vera natura della corsa al libero mercato, il monopolio. Non si spiegherebbe altrimenti, spiega Michéa, la tendenza alla formazione di trust, cartelli e accordi di ogni genere per tenere alto il prezzo delle merci in modo artificiale.
Liberalismo economico e liberalismo culturale, con particolare riguardo all’ideologia dei diritti dell’uomo, sono caratterizzati dal mito fondativo «di un individuo ritenuto “indipendente per natura” e definito unicamente attraverso il suo potere di sottrarsi in modo continuo a tutte le forme di eredità naturale e di contesto oggettivo, che si tratti, per esempio, della filiazione, della terra natale o della lingua madre» (p. 81).
Si entra qui nel campo di quella tendenza intrinseca della società capitalista all’annichilimento del genere umano già stigmatizzato da Rosa Luxemburg, annichilimento perfettamente incarnato dalla società utilitarista benthamiana: «“Cos’è in fondo una comunità?”», scrive Michéa citando Michael Sandel a proposito della filosofia politica di Bentham, «“un ‘corpo fittizio’ composto dalla somma degli individui che esso comprende”» (p. 45), un organismo che sottomette ogni ragionamento filosofico, ogni posizione morale o religiosa al calcolo e alla bilancia di costi e benefici, «primato strutturale di un ideale puramente calcolatore (o gestionale)» (ibidem) da sostituire a ogni ideologia.
Non è un caso dunque se la critica di Proudhon, di Marx ed Engels, degli anarchici delle origini, dei populisti russi come Elisabeth Dmitrieff, con tutte le dovute differenze, si fosse sviluppata come una critica alla nuova società capitalista e i suoi feticci tanto quanto al mondo del Ancien Régime, in difesa del popolo e della gente comune, l’artigiano, il contadino, l’operaio, il cameriere, dal vecchio mondo e dal nuovo mondo.
Se il trauma fondativo del pensiero liberal-illuminista-progressista sono le guerre civili e religiose di XVI-XVII secolo, come sostiene Michéa, e il suo nemico originario risiede nel vecchio mondo della Restaurazione, oggi, venuto meno il compromesso storico-filosofico tra la sinistra e il movimento internazionale socialista proletario volto alla lotta comune contro l’assolutismo e i regimi totalitari del XX secolo, la società liberale trova il suo nemico in qualsiasi forma di legame comunitario che possa opporsi alla dinamica assiologicamente neutra del mercato o costituire un’alternativa all’ideologia dei diritti dell’uomo.
«“Corri compagno, il vecchio mondo è dietro di te!”» (p. 12), è il motto del Maggio ‘68 ripreso da Michéa, l’atto di nascita della sinistra contemporanea in totale continuità con la sinistra liberale delle origini, «“vecchio mondo” nel quale – ironizzava Orwell – l’uomo della sinistra “progressista” potrà includere tanto “la guerra, il nazionalismo, la religione e la monarchia” quanto “i contadini, i professori di greco, i poeti e i cavalli”» (ibidem). Un autentico motto socialista dovrebbe invece suonare così: «“Non correre tanto compagno, il nuovo mondo – quello del riscaldamento globale, di Goldman Sachs e della Silicon Valley – è davanti a te!”» (Ibidem).
Come nota giustamente Michéa, se ancora nel 1964 gli studenti di Berkeley sfilavano con delle finte schede della IBM per protestare contro il complesso militare-industriale, già a metà degli anni settanta l’innovazione tecnologica era diventata, di per sé, una promessa di emancipazione e di progresso, la promessa di nuova età dell’oro da raggiungere alla fine della grande corsa all’innovazione. Oggi, a maggior ragione, gli insistenti tentativi da parte del capitale di regolare, orientare e trasformare, in una parola controllare, l’esistenza delle popolazioni occidentali e delle metropoli di tutto il mondo, dovrebbero aprire gli occhi sulla vera natura della gestione delle rivoluzioni tecnologiche.
“Dobbiamo continuare a spiegare come l’informatica sia un riassetto del mondo secondo una logica di razionalizzazione, di gestione di tutte le attività umane, di svalutazione dei mestieri, di rottura con l’esperienza percettibile, di rimodellamento dell’essere umano, di scomparsa dell’interiorità e di distruzione del legame sociale (p. 166)”
Come già dichiarato lucidamente da una delle figure storiche più importanti del liberismo: «L’economia è il metodo, ma il nostro obiettivo resta quello di cambiare l’anima dell’essere umano”. Margaret Thatcher, Sunday Times, 3 maggio 1981» (p. 10).
Nella società capitalista del XXI secolo il «principio liberale di estensione del dominio della lotta» (p. 15) è pienamente realizzato e il capitalismo stesso è ormai divenuto un «“fatto sociale totale”» (p. 185), cioè un rapporto sociale capace di dominare la totalità dell’esistenza umana sulla base di dinamiche autonome. Il progressismo liberale è il custode di tale ordinamento, «ogni passo avanti costituisce sempre un passo nella giusta direzione» (p. 27), mentre l’unico legame sociale possibile è quello del consumo, un «“dispositivo centrale dell’elaborazione identitaria”» (p. 78) odierna, dispositivo a cui si accompagna la sua appendice più importante: lo spettacolo (cfr. Guy Debord, La società dello spettacolo).
Una società atomizzata perennemente in movimento, perennemente «eccitata» (cfr. Christoph Türcke, La società eccitata. Filosofia della sensazione), una società quindi a cui viene negato lo spazio e il tempo necessari alla formazione di un qualsiasi tipo di legame. Anche così si spiega la crescita vertiginosa della comunicazione on-line, nel doppio senso di comunicazione in rete, quindi virtuale, e di una comunicazione sempre attiva, una vera e propria occupazione delle menti che rappresenta «una delle forme compensative tanto della continua erosione del legame da parte della logica commerciale quanto del correlativo declino dell’arte della conversazione» (p. 63).
Cosa ne è dunque della Gemeinschaft? Nell’«inverno del capitalismo» (p. 167) entrato ormai nella «“fase terminale della sua crisi strutturale”» (p. 170) la fede in un prossimo disgelo arriva dall’utopia progressista suprema, la promessa dell’uomo nuovo di silicone del transumanesimo. Vera e propria «religione del capitale» (p. 77), il transumanesimo porta alle estreme conseguenze, cioè alle radici del corpomente, la relativizzazione di ogni datità, biologica, culturale e psicologica, dalla società all’individuo, esso porta nel bios la neutralità assiologica rispetto a ogni identità, rispetto a ogni condizione entro cui l’uomo nasce e che quindi non è scelta, non è contrattata, non può essere mobilitata, modificata o calcolata.
Se il transumanesimo costituisce la frangia estrema del progressismo incarnato dall’eliminazione di ogni limite alle possibilità dell’individuo fluido, un individuo «coperto dalla testa ai piedi di microchip, biologicamente liberato dal pesante fardello del sonnellino» (ibidem), non è dunque molto difficile capire il perché della sinergia tra le istanze no border e no limit del liberalismo culturale e quelle dell’accumulazione senza limiti del capitale, tra l’atomizzazione della società e la fobia di ogni identità che caratterizza il pensiero liberal-progressista. Ne consegue l’incapacità di riconoscere il carattere dinamico, rivoluzionario e distruttore del capitalismo, visto e compreso dalla quasi totalità della classe intellettuale, «“agenti dominati della dominazione capitalistica”» (p. 131), come un fenomeno di natura reazionaria.
Le istanze comunitarie, in questo quadro, non possono che essere assimilate in tutto e per tutto a un insieme torbido «di stampo nazionalista o fascista» (p. 198). Per Gemeinschaft Michéa non intende altro che quello strato irriducibile, fondamentale e fondativo, di cui fanno parte le relazioni e i legami dell’uomo storico fin qui conosciuto, dell’umano ancora oggi esistente nei modi della sua spontanea organizzazione bio-sociale e nei suoi minimi termini morali, nei termini, cioè, della common decency di estrazione orwelliana. Tale common decency non è altro che quella solidarietà innata che viene osservata ogniqualvolta un evento straordinario e traumatico come un disastro naturale sconvolge la vita delle persone, un concetto che Michéa accosta anche a quello di «baseline communism» (p. 71) dell’antropologo anarchico David Graeber.
A caratterizzare fondativamente l’individuo della comunità è il desiderio di riconoscimento, ovvero il desiderio di occupare un posto in un quadro di relazioni e simboli che riposano su una rete di legami condivisa, una rete retta dal triplice intreccio del dare, ricevere, ricambiare, secondo l’antropologia del dono di Marcel Mauss. Ciò che regola i legami fondanti della comunità non sono l’interesse personale e la necessità dell’accumulazione delle risorse, ma il senso dell’onore e la generosità reciproca. Ogni identità culturale, politica, psicologica, trova qui il proprio terreno fertile, l’«orizzonte concreto della vita comune e della protezione dei beni comuni» (p. 198) in uno spazio e per un tempo comune.
Le classi medie iper-tecnologizzate e iper-connesse delle metropoli odierne, con i loro intellettuali-sacerdoti del progresso a oltranza, rappresentano il braccio armato della repressione di ogni forma di alternativa dal basso alla società capitalista, mentre le classi popolari sono lo strato dei perdenti della lotta di tutti contro tutti. Allo stesso tempo, è proprio la classe media metropolitana a costituire la vittima prediletta del sistema che difende, perché la più esposta alle dinamiche distruttrici di ogni identità e quindi sempre in attesa dell’avvento di una nuova rivoluzione che risanerà il vuoto esistenziale dei suoi componenti, mentre le classi popolari vengono sempre più spesso identificate come il nemico che cova l’eterna pulsione alla restaurazione del vecchio mondo a causa di un supposto odio per quello nuovo.
Per costruire un’alternativa alla situazione odierna in cui crisi finanziarie ricorrenti si affiancano sempre più alla già vista esportazione delle crisi socio-economico interne via guerre per procura, bisogna rinunciare all’attesa messianica di una improbabile rivoluzione-rivelazione tecnologica che salvi l’umanità da se stessa e concentrarsi, invece, sulla ricostruzione di uno spazio politico per la difesa di quel socialismo naturale della gente ordinaria (cfr. Machajski p. 76) che altro non è se non l’humus antropologico del vivere comune.
Il fallimento della creazione di un’alternativa filosofica, storica e politica efficace in tal senso, lascerebbe le popolazioni occidentali senza alcuna prospettiva futura se non quella dell’attesa di una fine violenta e improvvisa della società capitalista e, nel frattempo, la sola prospettiva a breve termine di una lotta per la sopravvivenza in un ambiente sempre più degradato e in una società sempre più pericolosa. Una condizione, questa, che sembra descritta perfettamente da una frase di Debord ripresa da Michéa a proposito del fallimento del riconoscimento delle istanze popolari da parte degli intellettuali, chiusi come sono nella loro «demenza ideologica» (p. 136) volta interamente alla realizzazione del «“mondo di domani”» (p. 156): «“In girum imus nocte et consumimur igni” (“giriamo in tondo nella notte e veniamo consumati dal fuoco”) Guy Debord, 1978» (p. 167).