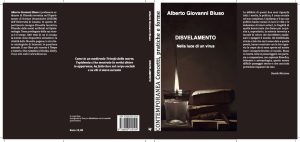Recensione a:
Alessio Musio
Baby boom. Critica alla maternità surrogata
Collana «Transizioni»
Vita e Pensiero, Milano 2021
€ 22,00
Pagine 273
di Sarah Dierna
Il 16 ottobre 2024 il Senato della Repubblica italiana ha approvato un disegno di legge che modifica l’attuale normativa in vigore sulla maternità surrogata. La modifica del comma 6 dell’articolo 12 della legge 40/2004 prevede che la maternità surrogata sia considerata un reato anche quando è compiuta fuori dall’Italia nei Paesi in cui tale pratica è legittima.
Prescindendo dai motivi per cui vi si ricorre, la gestazione per altri rimane una questione molto delicata anche perché implica la presenza di un terzo individuo coinvolto, e cioè colui che sarà portato al mondo. Mi sembra che le diverse posizioni nell’ambito dell’etica applicata alla vita siano spesso viziate dal retaggio laico o cattolico al quale si sente di appartenere ma una riflessione filosofica è corretta se va oltre queste etichette e analizza invece la questione con rigore e verità, senza pregiudizio ma con il giusto spirito critico necessario a cogliere la complessità del problema. Baby boom. Critica alla maternità surrogata di Alessio Musio offre al lettore una ricognizione completa e accurata su una faccenda di fatto molto scivolosa, come lo sono la maggior parte degli argomenti bioetici.
Si sta assistendo, con sempre più frequenza e su una molteplicità di fronti, a una «tendenza schizofrenica nei confronti della carnalità», la quale ritiene possibile «prescindere dal corpo e dalla carne o considerarli come una materia-prima sorda e indifferente» (p. 12).
Anche la pratica procreativa ha assorbito tale tendenza. Essa si serve sempre più spesso, e con sempre maggiore precisione, di strumenti tecnologici che intervengono e operano su più livelli. Accanto alle pratiche di controllo e di diagnosi, tali dispositivi sono riusciti ad assistere una coppia di genitori potenziali durante la procreazione, attraverso procedure di fecondazione in vitro. L’obiettivo è quello di raggiungere una completa autonomia produttiva:
Se guardiamo la generazione con gli occhi della tecnologia che permette la pratica della surrogacy ‘totale’ ci troviamo messi di fronte a ciò che in bioetica si chiama, con una strana espressione, ‘autonomia riproduttiva’, visto che grazie a essa diviene di fatto possibile riprodursi indipendentemente dall’altro corpo (quello femminile per l’uomo e quello maschile per la donna), dalla relazione materna, dall’effettiva presenza di un partner. Per ognuna di queste possibili dipendenze, infatti, il combinato tecnologico dato dalla FIVET e dalla surrogacy offre una soluzione e un surrogato: l’unione sessuale tra uomo e donna è sostituita dall’unione in provetta tra spermatozoo e ovocita, la differenza sessuale è sublimata nella differenza stessa tra i gameti, la relazione materna carnale è pensata, in via di premessa, come una semplice gestazione […]. Che di tutto questo, poi, ci si voglia servire da soli o con un partner di altro o dello stesso sesso è, dal punto di vista della tecnica, ininfluente (p. 24).
Dal punto di vista della tecnica soltanto, però. La generazione è in verità qualcosa di più sottile, profondo e intimo che passa, nella maggior parte dei casi e certamente quando un figlio è desiderato e voluto, dall’affettività di due corpi. E tuttavia la maternità surrogata non prevede né generazione né gestazione, non almeno per come comunemente concepiamo noi questi due passaggi fondamentali della prassi procreativa.
Per capire di cosa stiamo parlando il linguaggio è importante e Musio infatti ritiene più giusto e corretto parlare di maternità surrogata, anziché di utero in affitto. Questa seconda espressione della surrogacy fa emergere soltanto il luogo biologico e la logica economica, l’espressione di maternità surrogata invece è più puntuale in quanto mostra il nodo relazionale unico, enigmatico e insostituibile che è in gioco in questo tipo di prassi. Un nodo che ha bisogno della corporeità per sussistere. Il ventre non è soltanto un luogo e la madre non è soltanto una gestante; ne è una conferma la placenta: uno ‘spazio’ a partire dal quale la letteratura di Stefano D’Arrigo ha costruito un mondo, un tessuto che per natura e costituzione risulta ancora impossibile da realizzare in laboratorio, una realtà che «non appartiene di per sé a nessuno dei due corpi, quello materno e fetale, singolarmente presi: non preesiste nella madre, non preesiste ovviamente nel bambino, ma è per così dire da loro co-costituita». L’esistenza di questo involucro che un attimo dopo la nascita non serve a niente ma fino a un attimo prima rimane fondamentale e necessario «è un modo per dire che i corpi contano, che le relazioni non sono solo ideali, anzi che almeno nel caso del legame madre-bambino hanno carne, tanto da generare insieme un organo/tessuto che è il segno concreto della loro stessa unione, mostrando come il legame che insieme costituiscono non sia facilmente spezzabile, come si ritiene astrattamente nei dibattiti su maternità surrogata, né facilmente riproducibile» (p. 88).
Mediante la surrogacy, sia essa parziale o totale, la figura materna diventa una e trina, nel migliore dei casi si sdoppia ma in tutte le circostanze la surrogata autentica resta solo «una donna che non lascia alcuna traccia di sé sul piano genetico nel figlio che ha messo al mondo, come se il suo corpo fosse stato semplicemente un ‘dispositivo di passaggio’» (p. 16). La madre sociale lascerà certamente una traccia, soprattutto quando il figlio avrà acquisito una maggiore consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante ma, prima e oltre la sua presenza, rimane indelebile la traccia della madre genetica quando non coincide con il genitore sociale ma ha messo a disposizione il proprio materiale genetico che sarà fecondato nell’utero di una seconda madre per gli interessi di una terza. È probabile che il figlio manifesterà alcuni tratti della madre genetica: «Avrà probabilmente gli occhi proprio della donna che si sarebbe ‘limitata’ a rendere disponibile la cellula uovo o almeno in parte le somiglierà nel volto, nel sorriso, nelle fattezze fisiche» (p. 17); conserverà di essa i modi della carne senza tuttavia averla mai abitata; conserverà di essa le stesse tracce che il tempo lascia sul soma adulto senza tuttavia averlo mai vissuto insieme questo tempo.
A disincarnarsi non è soltanto la dinamica relazionale tra genitori e figli ma anche quella tra i generanti, l’accoppiamento dei quali rappresenta forse l’espressione massima dei corpi che siamo, della carne che ci costituisce e ci unisce. L’atto è la manifestazione della «più intensa unione che sia possibile immaginare sul piano della materialità del nostro esistere di corpi separati» (p. 261). La generazione, come relazione sessuale finalizzata a uno scopo, procreare, richiede l’incontro e l’interazione di due persone di sesso diverso; richiede l’attesa di uno specifico periodo temporale (fertile) che è il corpo stesso a decidere; richiede infine che lo spermatozoo e l’oocita appartengano a due corpi che si conoscono nella fisicità e nell’affettività. È questa relazione calda a ‘smaterializzarsi’ quando la generazione è affidata a delle fabbriche della fertilità: non si danno più un solo padre e una sola madre, ma del materiale biologico prima e dei genitori intenzionali poi; scompare la fecondazione ‘naturale’ ora sostituita da nuovi metodi di ‘raccolta’; la dinamica fisica e flussica dei corpi si spezza adesso in fasi differenti: l’autoerotismo per l’uomo, un intervento chirurgico per la donna; un terzo in ultimo, il figlio, frutto di un coito clandestino che per nove mesi ha transitato nel corpo di una madre che non era la sua.
Accanto alla corporeità relazionale Musio accosta giustamente la memoria del corpo (che poi non è altro che la memoria che noi siamo). «Come se i corpi non contassero e quello che di rilevante succede nella loro carne fosse privo di significato per la vita personale (biografica)» (p. 158). E invece i corpi contano. Nonostante la madre surrogata venga concepita come un luogo di transizione e accetti con un vincolo contrattuale tale procedura, nonostante siano messe in atto diverse strategie di bio–business per appaltare la maternità nella maniera più svincolata possibile[1], restano i vincoli dei corpi che non potranno mai essere ridotti a dei soli dispositivi dai quali si passa senza lasciare traccia. Lo testimonia la storia di Mary Beth riproposta da Musio. A Mary Beth era stata commissionata una gestazione per conto di una facoltosa coppia desiderosa di avere un figlio ma impossibilitata a farlo a causa della sterilità di uno dei due partners. «Per Mary Beth quella bambina che aveva in grembo e che avrebbe dato alla luce era semplicemente una fonte di reddito, con cui avrebbe in aggiunta potuto dare soddisfazione a un desiderio di discendenza di un uomo certamente benestante». Senonché per la surrogata «quella bambina nei lunghi mesi della generazione, nel sentimento fisico della sua presenza, nell’esserci di entrambe in quel tempo e in quel corpo, esce dal cono d’ombra dell’impersonale in cui era come stata incastonata, e diviene con sempre più forza e chiarezza, Sarah, la sua Sarah, il che null’altro vuol dire […] se non sua figlia, integralmente, senza riserve e scomposizioni» (p. 109).
Ciò che giustificherebbe, legittimerebbe e dovrebbe rendere la surrogacy possibile è il desiderio di avere un figlio: «Ciò che conta è avere il desiderio di un figlio: se esiste uno strumento tecnologico in grado di rispondervi – ed esiste, si chiama maternità surrogata e un domani utero artificiale –, ecco che automaticamente il desiderio diventa un diritto senza fare distinzioni tra chi ne è portatore» (p. 193). Si tratta di un diritto vuoto: è vuoto perché nulla sta a suo fondamento; è vuoto perché a soddisfarlo sarà un figlio che lo lascerà comunque vacante dal momento che «le cose e le persone che desideriamo […] non hanno mai la forma esatta del vuoto che abbiamo scoperto in noi desiderandole; né chi desidera può prevedere realmente come sarà la sua vita una volta ottenuto quanto desiderava» (p. 197); è vuoto perché è lo stesso desiderio dei desideranti a essere sostituito ora dall’humus di coltura del materiale biologico. È vuoto, verrebbe da aggiungere, perché la scelta accurata, attenta e riflettuta sui caratteri di terzi che si desidera trasferire al figlio e che portano i genitori a selezionare con cura i donatori biologici svuota di significato la stessa esperienza generativa che assomiglia assai più all’acquisto in negozio di un paio di scarpe. Con una sottile differenza: le calzature non risentono della vita con cui invece il nascituro dovrà fare i conti. Mi sembra che la surrogacy costituisca un esempio lampante del desiderio egoistico della genitorialità. Non si vuole soltanto un figlio, si chiede che sia in un certo modo; si chiede di non portarlo nel grembo ma di riceverlo già pronto; si chiede che abbia dei caratteri ma che non ne possegga altri; si acquista – appunto – come un qualsiasi altro prodotto commerciale.
Il libro di Musio mostra in modo chiaro, argomentato e intelligente la facies oscura della FIVET, consente di farsi un’idea studiata e attenta della questione, aiuta a cogliere le ombre nascoste dietro le possibilità che la tecnologia mette a disposizione dell’uomo.
La maternità surrogata cambia il modo di considerarsi figli, ridotti ora a merci cui appartiene uno specifico valore d’uso, quello che i genitori vorrebbero appagare con la sua presenza, e uno specifico valore di scambio, definito dalla madre genetica e quella gestante. Con la conseguenza, alla fine, di ritrovarsi il prodotto studiato a tavolino da qualcun altro. Figli biologicamente apolidi.
[1] «Le madri surrogate, invece, non devono essere molto giovani, in quanto si preferiscono quelle che abbiano già avuto dei figli, non solo perché meno rischiose dal punto di vista dell’effettiva conducibilità della gravidanza intesa come bene commerciale, ma perché – avendo già dei figli propri – sono meno a rischio di rivendicare, successivamente al parto, un loro legame con il/i bambino/i», ivi, p. 171.