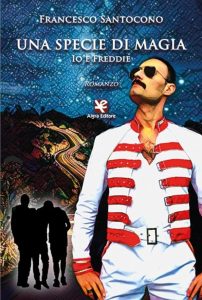di Enrico Palma ed Enrico Carmelo Tomasello
Una dea. Questo è Parthenope. Una creatura umana ma dalle sembianze divine, e anche una divinità dalle sembianze umane. Nata dalle acque, battezzata nel bellissimo golfo di Napoli che è un idillio di luce ed estasi di colore. Eppure, Parthenope non è solo la metafora di Napoli e della sua bellezza. Essa è una dea che rivela la verità, è uno strumento di visione, un meraviglioso incanto impastato dagli elementi. È una vera gioia guardare questa donna, e soprattutto vederla emergere come uno spicco di senso dal suo mondo, osservarla gloriosa, trionfante, gaudente nella vittoria della sua bellezza, appoggiata a una terrazza con vista sul mare di Napoli, adulata da tutti e da tutti desiderata, ma anche intristirsi, soffrire, angosciarsi. Quello di Sorrentino è un approccio greco sin dalla scelta della bellezza femminile come paradigma ontologico, perché, per i Greci, la bellezza fisica era una virtù al pari della forza, dell’acume e dell’intelligenza.
Anche per questa ragione Parthenope è divina, essendo sostanza di bellezza che racchiude in sé la magia, il segreto e l’essenza di un’intera città, di un intero popolo. Parthenope è la bellezza degli amori giovanili, così fugaci e intensi come poi non lo saranno più con l’avanzare degli anni; Parthenope è la povertà dei rioni di Napoli e delle sue mafie; Parthenope è il desiderio, che si manifesta in tutte le sue forme; Parthenope è la scrittura letteraria, l’idea a cui l’arte deve tendere per essere tale, l’immagine più reale di ciò che John Cheever ha perduto e che cerca nella parola dei suoi romanzi di ritrovare, tra passeggiate desolate e pianti affranti; Parthenope è il dolore della vecchiaia, della morte; Parthenope è il sogno di bellezza a cui l’umano aspira per guarire, nella forma sensibile di un assoluto, dalla ferita dell’esistenza, segnata irrimediabilmente dal dolore, dallo svanimento e dalla morte; Parthenope è anche conoscenza, ed è conoscenza dell’umanità, dalla più nobile a quella più sciatta, svelandone le ipocrisie e marcandone le nobiltà.
Che Sorrentino sia uno dei più fini antropologi del nostro tempo è un fatto ormai acclarato, una tendenza della sua cinematografia che rimonta in modo chiarissimo almeno alla Grande bellezza, in cui la fauna umana dell’alta borghesia romana viene passata da parte a parte dalla lente del regista, e che giunge al suo culmine indubbiamente nella parata carnevalesca, miserevole e tristissima di Loro. Antropologia che è la conoscenza dell’uomo, la scienza del vedere a cui si richiama il professore Marotta nell’ultimo incontro con Parthenope prima di aprirle le porte dell’accademia.
Il cinema di Sorrentino è penetrante poiché capace di creare i contrasti più forti e curiosi, come se il regista si compiacesse, alla stregua di un re spagnolo del Seicento, di contornarsi delle più diverse figure del grottesco umoristico, creando così una vera e propria corte di nani e di buffoni a cui in fondo si riduce gran parte dell’umanità. Scelta, però, che certe volte scade nello stucchevole, come la rivelazione dell’identità del figlio del professore o il corteo funebre per il suicidio di Raimondo, che non aveva sopportato il dolore di sapere che Parthenope fosse di altri, che la dea non fosse solo sua. Ma ci sono anche scene di sublime bellezza, come Parthenope agghindata con i gioielli del tesoro di San Gennaro, poi spogliata dal cardinale e infine eccitata sino all’orgasmo compiendo il vero miracolo dello scioglimento del sangue.
Ed è proprio il miracolo a essere la cifra di tutto il film, della poetica di Sorrentino, il miracolo che è l’argomento esistenziale di Parthenope, che è Napoli, che è l’esistenza negli attimi della sua acmé, in cui tocca l’apice della sua pienezza. Dall’oscenità conturbante del sesso, addirittura ritualizzato con sguardo antropologico nell’accoppiamento forzato dei giovani rampolli delle due famiglie criminali più potenti di Napoli, alla gloria sfolgorante della luce che rende quest’opera di Sorrentino un sollievo dalla torba del vivere.
La vita è come la Napoli descritta dalla diva in disgrazia Greta Cool, povera, afflitta, depressa, prostrata, meritevole in certi momenti di essere abbandonata, e tuttavia magnetica nel ricondurre sempre a sé, alla sua energia, che a volte erompe e altre involve. Parthenope soffre: anche gli dèi, allora, sono capaci di tristezza, di rinunciare anche alla vita che germoglia dentro di loro, nel momento dell’aborto in cui questo grumo di desiderio recede dalla generazione, rinuncia a mettere al mondo un altro mondo.
In cosa si sintetizza, dunque, l’esperienza antropologica del vedere, lo studio della verità nel modo in cui essa si dà come mostrarsi del suo stesso apparire? È curioso che un regista, nel proprio film, neghi alla sua musa una carriera di successo nel mondo del cinema, perché mancante del brio, dell’allegrezza necessaria a catturare il pubblico, a renderlo schiavo del sogno di bellezza che la diva deve incarnare. Parthenope sceglie la conoscenza e il modo scientifico di farla, all’università, con tutte le sue storture e con tutti i suoi limiti. Dopo aver visto, sceglie di attraversare il tempo del mondo che è la vita conoscendo. Più precisamente guardando, che, del resto, è la forma più originaria del sapere, anche filosofico: il theorein, il fare teoria, quindi sapere, osservando.
Va via da Napoli, smette di essere dea volubile e capricciosa di bellezza e ripara a Trento, da cui tornerà soltanto anziana, nella tristezza del finire della vita in cui Napoli, la vera dea, la vera vita universale di cui le esistenze singole non sono altro che increspature accidentali, che a volte gioiscono ma che purtroppo più spesso piangono, resterà con la sua festa, i suoi colori, l’esorcismo continuo del dolore, esemplato nel carro trionfale, come in una sfilata militare, in cui l’esercito giubilante partenopeo esulta per la grande vittoria dello scudetto. Napoli, la vita, il mondo, sono questa festa, che nella malinconia della luce ricorda che a essere malinconica non è la luce in sé, non è lo splendore degli affacci sul Golfo, è lo sguardo che li osserva, i quali, nella conoscenza, compiono il timido sforzo di imitarne l’intatta durata, riuscendovi, forse, per qualche raro attimo di divina bellezza.
«Voi sapete che tutte le cose in Napoli, dalle pietre al cielo, sono innamorate» con questa epigrafe Matilde Serao introduce la sua raccolta Leggende napoletane. Ed è così che appare la prospettiva di chi osserva la giovane Parthenope stare al mondo. Quel mondo illuminato ed autentico proprio perché è lei a conferirgli significato. Il suo miracolo è apparentemente sotto gli occhi di tutti ma inaccessibile a molti. Sembra che non si riesca ad accogliere pienamente il momento in cui avviene, perché il miracolo sfugge e non si concede mai all’osservatore. Ancora una volta, niente riesce ad occultarsi meglio dell’evidenza.
D’altra parte ciò che Sorrentino mostra è la Parthenope (custodita nell’immaginario popolare) nata dalle acque del golfo di Napoli. Quello che resta difficile da cogliere è l’ispirazione da cui nasce il personaggio Parthenope. Come ha confessato lo stesso regista, la sua genesi intuitiva proviene dalle pagine del romanzo Viaggio al termine della notte. In quest’ultimo, il protagonista Bardamu ritrae l’ineffabile bellezza di un’infermiera che dorme. Dunque, l’immagine della donna dormiente diviene idealmente quella della bellezza irresistibile a cui non ci si può opporre. Così come accade nelle scene in cui la giovane invita i suoi ospiti ad osservarla all’interno di una carrozza regalatale alla nascita.
Luogo del riposo, della sospensione e dell’estasi, la carrozza è un feticcio camaleontico. Nel corso della sua vita può assumere le sembianze della culla, del letto matrimoniale e del carro funebre. La carrozza è allegoria dei manierismi e degli eccessi connotanti la cultura napoletana e più in generale di tutto il Sud Italia. Di un popolo che pur avendo poco o nulla offre tutto. Della sua proverbiale furbizia nata per necessità e non per scelta, dei mascheramenti e delle messe in scena che intrattengono e concedono tregua alla sofferenza quotidiana. Un’arte addomesticata tra le vie di una città che non dorme mai e su cui veglia un vulcano, parte insostituibile di quel logos che pulsa incessantemente. In aperta opposizione a ciò, risuonano le provocazioni pronunciate dall’attrice Greta Coll, nel suo magistrale monologo rivolto al pubblico di napoletani presenti in scena:
“Siete poveri, vigliacchi, piagnucolosi, arretrati, rubate e recitate male. E sempre pronti a buttare la croce addosso a qualcun altro, all’invasore di turno, al politico corrotto, al palazzinaro senza scrupoli, ma la disgrazia siete voi, siete un popolo di disgraziati. E vi vantate di esserlo, non ce la farete mai […]Io mi sono salvata, ma voi no. Voi siete morti”.
L’altro tema che fa da sfondo alla pellicola, oltre al miracolo, è il tempo.
“A cosa stai pensando?” È la domanda che accompagna costantemente la giovane protagonista. Ed è una domanda aporetica, a cui molti tentano di dare una soluzione ma inutilmente. Forse perché nessuno dei personaggi ha l’audacia di svincolarsi dall’illusione, che nell’alternarsi di risposte e silenzi della giovane Parthenope ci siano: conoscenza, saggezza e verità. Eppure sono diverse le volte in cui la protagonista dichiara socraticamente di non sapere o di non essere adeguata a un ruolo. Questa inadeguatezza è connotata da una profonda solitudine, in particolare in quelle scene in cui si trova a essere tra agli altri pur essendo esistenzialmente sola.
Con Parthenope si esclude la possibilità di litigare, non esiste spazio per una banalità come il litigio. Desiderata da molti, Parthenope è come una donna che hai amato, con cui non vedi l’ora di tornare, ma che dopo un po’ diventa intollerabile. Parthenope è indiscutibilmente una pluralità di mondi. È contemporaneamente: una città, una donna, un desiderio, un canto ed un anelito di perfezione. Nonostante ciò la sua presenza è costantemente inquieta e malinconica.
Alla fine sorge spontanea una serie di interrogativi. Se realmente assistiamo ad una truffa, ogni qualvolta frequentiamo l’inganno dell’innamoramento nei confronti di Parthenope, perché continua a sopravvivere il suo desiderio? Perché la sua essenza, che coincide con i connotati della città e della cultura che sintetizza, appare ancora miracolosa? Ed infine, senza mezzi termini, Parthenope è davvero un miracolo?
Ciò che possiamo dedurne non è una risposta univoca ma due prospettive sulla protagonista. Dal punto di vista dell’innamorato è certamente un miracolo, mentre dal punto di vista demistificato della conoscenza potrebbe essere una truffa. Ancora una domanda. Quando sarà possibile vedere chiaramente? Probabilmente alla fine, proprio perché la vera conoscenza arriva quando resta poco da vivere. Alla fine Parthenope non è altro che la custode di questo paradosso.