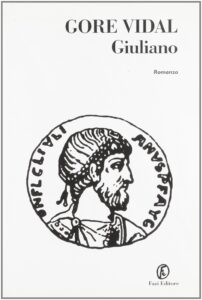Recensione a:
Alberto Giovanni Biuso
Tempo e materia. Una metafisica
Leo S. Olschki Editore
Firenze 2020
Pagine 168
€ 33,00
di Federico Nicolosi
Nitida nell’argomentare, incalzante nel domandare, probante nelle conclusioni, la metafisica di Tempo e materia è il tentativo estremo di far ritorno alle origini del pensare umano, presso la saggezza della parola greca; non già un ritorno – si badi – che è rifiuto approssimativo degli sviluppi contemporanei di una filosofia che vuol annunciarsi sempre più drasticamente (e, il più delle volte, risibilmente) “post-”[1], ma un cammino che è l’indispensabile “eterno ritorno” della metafisica sui passi di quell’ormai smarrito domandare originario da cui proviene.
La metafisica di Biuso, radicalmente materialistica e antropodecentrica, si propone così di «comprendere ciò che siamo dentro l’intero che noi non siamo»[2], non subordinando solipsisticamente l’essere (existentia) degli enti al loro mero esser-conosciuti da un umano, bensì al contrario sforzandosi di comprenderli nella struttura diveniente e pur immutabile da cui di volta in volta si staccano rendendosi accessibili a un corpomente conoscente. Questa struttura si chiama Tempo, o parimenti (e forse più correttamente) esseretempo; la condizione del suo darsi è quell’incessante, ineliminabile e sempre dinamico attrito tra identità e differenza che senza sosta anima il presentarsi e lo scomparire degli enti dal mondo, ovvero il loro emergere (come differenza) dall’Intero e il loro rientrarvi, mutando forma e a un tempo rimanendo ciò che sono. Capire questa dinamica, e muoversi ermeneuticamente al suo interno, vuol dire anche riscoprire nella metafisica il fondamento di ogni filosofia e della Filosofia in quanto cifra precipua della condizione trascendente, dunque appunto metafisica, propria dell’umano. Il che, nelle parole da Heidegger pronunciate durante la celebre prolusione magistrale tenuta nel luglio 1929 all’Università di Friburgo, suona: «Sofern der mensch existiert, geschieht in gewisser Weiser das Philosophieren»[3].
Poiché – come l’autore del libro ha oculatamente messo in luce sulla scorta della prima sezione di Sein und Zeit – gli enti non sono mai colti atematicamente dall’umano, ma da questi sempre conosciuti nelle loro relazioni con la pluralità degli altri enti, «ogni cosa è dunque costituita di mutamento interno e di relazione con l’alterità. […] A ogni ente appartiene il proprio divenire, inteso sia come processo interno sia come effetto e causa rispetto a molti altri enti. Essere qualcosa significa diventare qualcosa»[4].
In una ontologia così profondamente relazionale, che intende l’essere come ciò che trascende l’ente nella misura in cui costituisce l’eventuarsi della differenza nel tempo, gli essenti non possono esser che «grumi di tempo» infitti in quella «cifra prassica e metafisica della vita»[5] che è la finitudine, l’irreversibilità, l’unidirezionalità. L’ente, nella sua presenza, sarebbe pertanto un evento di cui un dispositivo cerebrale soltanto non è in grado di avvertire il mutamento. In un quadro teoretico di questo tipo, l’ermeneutica assurge a «cronosemantica come orizzonte di comprensione dell’essere»[6]. Un essere che non semplicemente si dispiega nel tempo, ma che traluce come tempo che intesse ogni cosa vivente e non vivente, nella “immobilità diveniente” e policroma dell’istante-ora che definisce irriducibilmente il senso della temporalità come il co-occorrere simultaneo di ritenzione del “già” e protensione verso il “non ancora”. Ogni ente, quindi, «rimane nel tempo ciò che è ma nel tempo muta a ogni istante. […] Non va però verso il non essere, in direzione del ni-ente ma si dirige verso il non ancora implicito nell’essere stato»[7].
L’inemendabilità della nostra natura squisitamente temporale è suffragata dagli sviluppi più recenti delle neuroscienze, che ci confermano l’inesistenza di aree temporali specializzate all’interno del cervello umano, lasciandoci desumere che questo sia tout court votato e rivolto al futuro. Ma, di nuovo, il punto non è che noi siamo fatti di tempo, bensì che il mondo – dunque, noi in quanto parte di un tutto – è tempo simpliciter; tempo che si fa materia, che si fa spazio: Zeitraum. Non una mera grandezza fisica quantificabile e rappresentabile (perciò, passibile di sperimentazione in laboratorio) come la stragrande maggioranza delle fisiche “della reversibilità” hanno voluto far credere, non una “quarta dimensione” per l’umano soltanto inintelligibile; ma divenire orientato e irreversibile. Come dimostrano la termodinamica e il fenomeno dell’entropia in particolare, «mutamento e movimento costituiscono infatti la regola, non l’eccezione»[8]. Il fatto che l’universo, sia pur solo per mere ragioni probabilistiche, tenda al disordine, che da un bicchiere frantumato non sia mai più possibile ricavare quel bicchiere che sussisteva prima, porta in ultima sede il filosofo a suggerire una «storicizzazione della fisica-chimica poiché il tempo intesse la materia, poiché la materia è tempo»[9]. Affermare così veementemente che il tempo è materia, vuol dire anche che negare il tempo (compresa la sua unidirezionalità non suscettibile di replicazioni sperimentali) significa scadere in un vero e proprio nichilismo ontologico.
Muovendo ancora una volta da un rilievo fisico, Biuso non intende affermare cionondimeno che il divenire continuo e irreversibile che intrama il mondo sia un mutamento ontologico, un mutare di “ciò che c’è” (verso, evidentemente, un nulla), bensì un mutare fenomenico di “come ciò che c’è è”[10]. In seno a un tal quadro, «l’ontologia è la comprensione dell’essere come pienezza e insieme come abisso che non può essere fondato su altro ma costituisce il fondamento sempre in divenire del divenire degli enti»[11]. È infatti ancora l’incessante dinamica di Identità e Differenza a render conto – se non di che cos’è – di come si dà quel che chiamiamo “tempo”, dunque dell’essere umano in quanto tale. Asserisce a gran ragione il già citato Guido Boffi, commentando il capolavoro fichtiano: «In ogni sua apertura l’io apre la propria anima al polemos-dialogos che intrattiene fra sé e sé e con il mondo. […] L’origine è identità, che è differenza; è differenza, che è identità. È Uno, che è Due; è Due, che è Uno»[12]. L’umano, che per lo più è portato a rinnegare l’intenso e sempre cangiante gioco donde fluisce la sostanza del suo stesso essere, è da parte a parte questa “volontà” di far di due uno, di annegare la differenza in in-differenza (invece di riconoscerla in seno all’identità da cui si stacca); bisogno di ricongiungersi a quell’unidualità da cui sente di provenire. Volizione, questa, che si manifesta ontologicamente nel desiderio – costrutto fondamentale dell’essere dell’umano – ed esistentivamente nelle determinazioni empiriche di quest’ultimo, ad esempio nel desiderio amoroso che di questa pretesa (contraddittoria) è impregnato.
Quindi, se «l’essere è divenire anche perché tutto ciò che esiste è intriso di energia e di desiderio. Due termini, questi, che indicano lo stesso evento da differenti prospettive»[13], fa bene Alberto Giovanni Biuso a definire quell’«impasto di scintilla dionisiaca e cenere titanica che chiamiamo umano»[14] una «macchina desiderante» il cui amore «è sempre di sé e per sé» e tutt’al più mediato dalla cosa amata. Difatti, la psicoanalisi ci conferma che i “due che vogliono esser uno” rimanendo due (qui la contraddizione dell’amore e del desiderio), a cui poeti e filosofi hanno consacrato migliaia di pagine, ricercano invero, tramite la loro duplice pretesa prometeica e narcisistica di assimilazione dell’oggetto d’amore, il sé ideale che vogliono essere nell’altro[15]. La qual cosa non soltanto smentisce l’erronea natura di fine di cui comunemente è investito l’amato, provandolo niente più che mezzo, ma attesta nuovamente la disposizione ineludibilmente progettuale ed ex-centrica, dunque sempre protesa in direzione del non ancora e mai ferma al mero “ora”, dell’animale umano.
Districarsi ermeneuticamente dentro questa complessa dinamica temporale di identità e differenza che dà vita all’ente che noi siamo e a ogni cosa che ci sta d’intorno vuol dire, secondo Biuso, anche accostarsi al senso più profondo della differenza ontologica tra l’essente e l’essere, rettamente inteso quest’ultimo come ciò che nella sua nientità “fa essere” l’ente:
Soltanto il fatto che l’essere in quanto tale non si vede né si potrà mai vedere rende comprensibili le sue forme, le strutture, gli istanti. La lieve e insuperabile trasparenza dell’essere è la condizione dell’esistenza dell’intero dentro l’insieme senza fine e innumerabile delle sue manifestazioni[16].
Quella cui Biuso fa riferimento col nome di «trasparenza» dell’essere, ovvero appunto il suo esser ni-ente, rivela il «fondo dell’essere» – per dirla con Aristotele – quale sostrato originario che è condizione dell’apparire e del lasciarsi conoscere di tutti gli essenti. Pertanto, come osserva perentoriamente l’autore dimostrando uno straordinario acume logico-linguistico, oltre che teoretico, «il principio non consiste nel fatto che niente è senza fondamento – che tutto dunque debba avere una causa – ma che niente è senza fondamento, che dunque il fondamento è l’essere»[17].
L’essere, che in sé è identità indistinta e indistinguibile, viene alla luce nella differenza degli enti che da esso sono lasciati essere; questi ultimi, a loro volta, si arresterebbero a una piatta e assoluta diversità se non fossero esperiti da un corpomente conoscente nell’identità che li raggruma, nell’identità che sono. La circumspectio del Dasein heideggeriano non è solamente un modo dell’essere umano di dimorare il mondo e di far esperienza degli enti che lo circondano; è il modo d’essere (e di darsi) eminente dei medesimi enti, i quali, isolatamente dalla catena di rapporti che intrattengono gli uni con gli altri, non soltanto non sono conoscibili né esperibili dall’uomo, ma – questo è il punto – semplicemente non sono, non sussistono. Perché questi, in quanto processi sempre divenienti, sono anzitutto relazionalità, interazione, scambio, pluralità; e ciò è possibile perché sono unica, coesa, omogenea identità. Un’identità perpetuamente differenziantesi che è tempo in atto; tempo materico.
La distinzione tra l’adesso che sta e l’adesso che diviene è il nucleo più profondo della differenza ontologica. L’adesso che sta sono gli enti. L’adesso che diviene è l’essere, la sua differenza, il suo attrito, la sua trasparenza. […] L’essere del tempo è il suo divenire, la differenza ontologica è la temporalizzazione dell’essere[18].
Uno e immisurabile, l’essere è la luce che risplende dal mondo degli enti. L’umano è la possibilità dell’evenire di questa luce; la possibilità, cioè, dell’ente incontrato di farsi luce, di venire alla luce dell’essere, di essere: detto nel linguaggio immaginifico e criptico del “mago di Meßkirch”, «l’uomo è quell’essere-presente che, in quanto illuminante-percipiente – e così raccogliente – lascia che l’essente-presente sia come tale nel non-esser-nascosto»[19].
Scaturente da una fluida mescolanza di natura – l’animalità che gli è propria e che condivide con il resto dei viventi – e cultura – le affezioni, i vissuti, l’esposizione a stimoli sociali, culturali, politici di natura sempre nuova –, l’umano è l’incarnazione di questo giuoco fatto di identità plurale e di diversità unitaria. L’asinina riluttanza con cui questi, a partire dall’Umanesimo, sembra sempre più volersene distaccare non può che lasciar insorgere dubbi profondi circa la reale, e così esaltata, intelligenza di questo animale, donde le melanconiche note su cui si congeda l’autore:
Rispetto all’intelligenza di altri animali, indubbia e profonda perché l’intelligenza è in primo luogo la capacità di sopravvivere in un ambiente dato ed è dunque presente per definizione in tutte le specie che sono ancora vive, è naturale chiedersi in che cosa davvero consista l’intelligenza umana se è capace di porre a rischio la sopravvivenza di se stessa e dell’intero pianeta[20].
La risposta a tutto questo, ancora un’ultima volta, è filosofia. Filosofia che è metafisica. Una metafisica dell’immanenza e risolutivamente antropodecentrica capace, mantenendosi nell’ascolto degli enti, di dar loro luce, lasciando che risplendano nella giocosa reciprocità che li tiene insieme. Una comprensione del senso dell’essere profonda e genuina che conduca da ultimo, sul piano etno-sociologico, a una «antropologia disincantata, davvero materialistica perché radicalmente immanente e nello stesso tempo capace di cogliere nella cultura il proprium dell’animale uomo»[21], indipendentemente da ogni sommovimento autoritario e pervasivo del presente che questa dinamica la voglia adombrare.
[1] Guido Boffi, nel suo denso saggio introduttivo all’edizione Bompiani della Dottrina della scienza di Fichte da lui curata, ha dedicato parole taglienti a questo proposito, scorgendo nella vacua fuga dalla metafisica che il progressismo filosofico ha portato con sé negli ultimi decenni un profondo travisamento dell’essenza stessa della filosofia. Cfr. J.G. Fichte, Fondamento dell’intera dottrina della scienza (Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre, 1794), a cura di G. Boffi, Bompiani, Milano 2003, pp. 15-16.
[2] A.G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2020, p. 2.
[3] «Fintantoché esiste l’uomo, accade il filosofare»; M. Heidegger, Was ist metaphysik? (Che cos’è metafisica?, 1929), in Wegmarken, GA, Band 9, a cura di W. Von Hermann, Verlag Vittorio Klosterman, Frankfurt am Main 2004, p. 122. Questa inferenza, che è entrata di diritto nell’abbecedario filosofico di molti pensatori (ivi compreso, Biuso), ha in verità non pochi precedenti nella storia della filosofia. Da Aristotele al criticismo kantiano, è stato spesso ribadito, infatti, che «la ragione umana, anche senza il pungolo della semplice vanità dell’omniscienza, è perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quei problemi che non possono in nessun modo esser risolti da un uso empirico della ragione o in base a princìpi su cui esso riposa; e così in tutti gli uomini una qualche metafisica è sempre esistita e sempre esisterà, appena che la loro ragione si innalzi alla speculazione»; I. Kant, Critica della ragion pura (Kritik der reinen Vernunft, 1781), a cura di P. Chiodi, UTET (Mondadori), Milano 2023, p. 88.
[4] A.G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, cit., p. 7.
[5] Ivi, p. 23.
[6] Ivi, p. 34. L’eco heideggeriana di questa definizione è manifesta e voluta. Non casualmente, il filosofo tedesco dichiarava nell’Introduzione alla sua opera principale di voler interpretare il tempo come «il possibile orizzonte di ogni comprensione d’essere in quanto tale»; M. Heidegger, Essere e tempo (Sein und Zeit, 1927), trad. di A. Marini, Mondadori, Milano 2022, p. 13.
[7] A.G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, cit., p. 37. Con parole non molto dissimili, Emanuele Severino, rileggendo la parola parmenidea filtrata della propria metafisica immanente, ha osservato: «Il divenire che appare non è la nascita e la morte dell’essere, ma il suo comparire e scomparire. Il divenire è cioè il processo della rivelazione dell’immutabile»; E. Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi Edizioni, Milano 1995, p. 89. La differenza sarebbe, insomma, anche per un pensiero dell’essere apparentemente statico come quello di matrice neo-parmenidea del pensatore di Brescia, condizione dell’apparire dell’identità, che altrimenti sarebbe solo sterile in-differenza. Generazione e corruzione, che sono la manifestazione forse più radicale della differenza, non sono così processi in cui ne va dell’essere (nella sua struttura identitaria), ma soltanto del suo palesarsi: non una vacua negazione del divenire, ritengo quindi, ma ancora una sua radicale affermazione che ne disvela la scaturigine ontologica più autentica.
[8] A.G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, cit., p. 60.
[9] Ivi, p. 63.
[10] L’entropia ci insegna infatti che, nell’irreversibilità del mutamento della materia, questa rimane sempre conservata nella sua quantità complessiva, limitandosi a tendere – dentro l’identico che è – a uno stato sempre più caotico che è la massima differenza possibile. Cfr. ivi, pp. 65-80.
[11] Ivi, p. 85.
[12] J.G. Fichte, Fondamento dell’intera dottrina della scienza, cit., p. 96.
[13] A.G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, cit., p. 113.
[14] Ivi, p. 107.
[15] Cfr. S. Freud, Il disagio nella civiltà (Das Unbehagen in der Kultur, 1929), a cura di S. Mistura, trad. di E. Ganni, Einaudi, Torino 2010, pp. 51-54.
[16] A.G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, cit., p. 86.
[17] Ivi, p. 114.
[18] Ivi, p. 129.
[19] M. Heidegger, Il detto di Anassimandro, in Sentieri interrotti (Holzwege, 1950), a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 326-327.
[20] A.G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, cit., p. 147.
[21] Id., Ždanov. Sul politicamente corretto, Algra Editore, Viagrande 2024, p. 63.